| chi sono | Alessio Brandolini | che cosa ho scritto |
 Tevere in fiamme Azimut, Roma, 2008 |
La quarta di copertina
| Le poesie di Tevere in fiamme sono percorsi dell’esistenza, mappe lacustri, fluviali, marine (oltre al Tevere, il Circeo e i laghi laziali) fin su per i Colli Albani. |
Una scelta di testi della raccolta
Da qui vedo il paese, in alto sulla destra Il fischio vibrante delle canne è spronato Ora mi lascio sfoltire dall’erba Se potessi parlarti un giorno Quello non era un sogno Uccelli della notte mettono il becco nella luna dei nostri occhi Mi ritrovo uno scalpitio di puledri nel petto Così resisto ai colpi del tempo, addolorato ma non sconfitto A volte osservo ad occhi chiusi come avrei Le branchie slargate Divido con gli squali di passaggio Ora se parlo qualcuno mi ascolta. Infatti lungo il Tevere oggi le auto in coda ardono l’aria Questo stormire d’acqua è il pianto che piove dentro. Essere costretti alla forca Buccia d’arancia la basilica di San Pietro Colpito proprio in mezzo E non dimentico nulla del giorno La notte è un foglio bianco ricoperto di solchi profondi Cola a sorpresa il sogno (dopo anni avviliti dall’oblio) Senza gloria mi piego per raccogliere Indosso le tue parole che un giorno a Eugenio Montejo, in memoria La città eterna ci rovina addosso, non bastano le palafitte Crolla addosso la pioggia di settembre giugno 2008 avevo bisogno del tuo sguardo d’occhi nel frattempo non trascurerò
La poesía cruza la tierra sola,
apoya su voz en el dolor del mundo
Eugenio Montejo*
Di notte la vita ha frammenti di bellezza
nascosti nelle voci suadenti delle foglie
quando si staccano dai rami e lente
planano sull’asfalto, sui sacchi d’immondizia.
lo stesso che ha scolpito questo cuore
fitto d’oscure macchie e pietra grezza
che cede alla polvere i petali della sua pigrizia.
dal vento che trascina con sé le tracce
di fiumi asciutti, o in fiamme,
di territori assetati e sconvolti in questi giorni.
con gli occhi chiusi poto i ciliegi
ma l’esodo dalle ferite è il frutto che ci afferra
e alimenta la voglia di ripartire dall’inizio
perché la bocca ha le sue aguzze spine
a sigillare i ricordi, i fiori carnosi della savana.
*
Di più non posso
sottrarmi alle tenebre, all’abisso
nel mare chiuso in uno specchio
e scalzo andare incontro al figlio
con le mani assicurate a un fosso.
ti racconterei dei bisbigli
d’ali del pappagallo chiuso
in una gabbia messa in mostra
in un salotto ingombro di sbadigli,
delle doglie dopo il parto respinto
dei toni aspri che scacciano la luce.
ma realtà spalmata nello sguardo
con la camicia sudata e le scarpe
sprofondate nel fango, i tacchi
sbattuti sulle pietre consumate
dal cammino e del suo esatto contrario.
La nuvola che sorvola i giorni lesta arpiona i sogni
con dolcezza porta via la pelle e i grani del rosario.Dà fuoco alla città e al bosco. Guarda:
adesso persino il Tevere è in fiamme!
*
Mi rivolgo al caldo tropicale per il piacere che ho della luce
con il tiepido sussurro emanato dal sordo che ascolta il sole
la devozione del sarto che a occhi chiusi si cuce le labbra
lo scuotimento dell’animale dalle zampe annodate al collo.
Sulle spalle le spine delle rose, le schegge degli alberi,
le pietre ancora calde di case e palazzi divorati dalle bombe.
lasciano un segno d’ali leggere, di rientri in punta di piedi.
Di ricordi vaporizzati dal sale
di uomini dallo sguardo onesto
del regolare fluire delle stagioni
di nidi di grano e spighe di frutti
di fiori di fumo che salgono dalla legna che arde
del piacere del corpo rivestito con borchie di rame.
un passaggio di piume, una fuga di iene assassine.
*
Di notte fodero il buio con spessi strati di neve
e immobile ascolto le cicale che da sempre
ci respirano accanto o si nascondono nelle nostre vene.
mi fascio la fronte di spine, metto nei denti il veleno giusto.
Nel flusso sciolto dal sogno c’è sangue dappertutto
di madri e padri che in guerra hanno perso il figlio.
Al rallentatore rivivo il viaggio dell’indeciso
del pazzo ubriaco e trafitto da foglie di banano, platano o fico.
voluto che fosse il mondo
e ascolto il triste scoppiettio del forno
annuso e sfioro con le dita il pane
bianco a lievitazione naturale
i decenni spesi (e ormai persi) a farsi del male
a scagliare parole di sconforto sulle navi in fuga d’Ulisse.
*
Dialogo tutto il giorno coi pesci tropicali dagli elettrici colori
stando in ascolto delle stelle da rosicchiare in silenzio
delle cicale rinchiuse in bolle d’aria che fanno tanta tenerezza.
dal prossimo tuo
odiato come te stessa.
Risalgo in verticale
afferro la superficie
esplodo in cerca
di un soffio, con te
chiusa tra vetro e mare
la faccia dilatata
di osservatrice inquieta.
la tenera mollica, la crosta dorata
l’uva matura di mio padre
ma solo a te
ho aperto un varco tra le canne
in quel sogno di baci profondi
poi fatto a pezzi dal grido del corvo.
*
Questo stormire d’acqua non è un suono
atavico come tu dici, ma la fontana
di Trevi e sulle foglie dei platani
disposti a croce non sta scritta la vita.
Da lì non scendono gemme dorate
ma punte di lance che si conficcano
nella carne marcia dei pesci d’acqua dolce
e nelle teste dei passanti: puoi vederli a lungo
in ginocchio a raccogliere frammenti, ricomporre
con scrupolo il puzzle della memoria, delle emozioni.
le pallide cortecce dei platani, il volto ustionato e stanco
delle città-mondo che alla svelta s’espandono senza freni.
Al padre vorrei dire ciò che sento
portargli in dono non la rabbia per la terra maltrattata
ma l’inutile scheletro per seppellirlo con questi versi
in un’urna romana sotto il paese medievale
dove sono cresciuto all’ombra della torre campanaria.
Alla madre una semplice e docile preghiera
di pietre taglienti che il tempo ha trasformato in pane.
a mostrare il danno irreparabile.
Così il sarto che a se stesso cuce gli occhi
e più tardi, con destrezza, anche la bocca.
*
Grandinata di parole sparate dal silenzio
strapazzato dai tubi di scarico delle auto
dei bus lunghi una quaresima voluti dal sindaco ecologista.
Da un pensiero antico nascosto tra foro d’Augusto e le torri
le dighe di calcestruzzo di Tor Bella Monaca, del Prenestino.
con il papa tedesco a Istambul sceso nel fiume
nella visione d’amore che abbraccia il nemico.Così capovolta è una barca
la cupola va in fuga e lesta
arriva all’altra sponda latina
dove la chiesa cattolica
ha indorato regimi di tortura.
all’osso che ci sostiene
assieme a ogni tipo
di sospetto, coi lacci
delle stelle attorcigliati al collo.
nemmeno al buio, o sotto tortura.
*
Un paio di labbra screpolate dal freddo
fissano a lungo Roma murata dalle auto
poi si stringono a sottile, oscena fessura
cerniera di rame e d’acciaio, antiscasso
punto esclamativo scoppiato in silenzio
in combutta con l’odio che ancora perdura.
di terra grassa macinata lentamente da silenzi oceanici
dove gli alberi del lungotevere organizzano una danza
con i fili spinati che giungono dalla Palestina
le tremule luci di Castel Sant’Angelo riflesse nell’acqua.
di scucire le labbra
e lanciare un grido
affondare i denti avvelenati al collo gelido del tuo dio.
*
Agli occhi appenderò il sorriso e la rabbia
non mi chiederò se dormo o son desto
e la notte è solo un residuo di luce gialla
o se questa gioia è il nostro umile concerto.
Coi baci volevo spogliarti dal dolore e dall’esilio
le mie dita legate al tuo corpo erano una grancassa
la lingua lo svelto violino che scioglieva ogni dubbio.
i granelli di polvere che ci conoscono.
Verranno lune più dolci? altre pietre?
ci sorrideranno fiumi più limpidi?
terre da arare e difendere a denti stretti?
mi avvolsero di nebbia luminosa.
Ora che non ci sei ti mostrerò altre storie
farò i conti con gli osti, i vivi e i morti,
con il vento divino che strapazza le foglie
incunea tra sole e luna lo sposo e la sposa.
*
né il verde profumo della savana. Ai tropici fa freddo
e a volte cade persino la neve.
Sono stato sotto i ponti e ho visto le tenebre
le croci, il fiume tagliato in due dall’oceano dei liquami
il tatuaggio di nuvole sulla pelle strappata alle lucertole.
i conflitti sul lavoro con le scimmie ammaestrate
i pugni allo stomaco dati e ricevuti
la manciata di chiodi che segnano il percorso
gli alberi strappati alla terra, le menti telecomandate.La ripresa del sogno
I lampi sinistri del Tevere illuminano gli sfregi sul volto della Terra.
perso al volo, in salita
bagna il becco nel nero delle strade
nella calma dei buoi che trascinano
le foglie dei platani, degli ulivi
persino dei banani dove sta scritta la vita.
Nel paesaggio saldo e assoluto delle rovine che ci rotolano addosso
oggi trovo un canto e ti vengo incontro (se posso, se me lo permetti)
negli occhi la luce sfibrata ma tenera di Roma
sulle spalle le pietre del fiume. E questa voce che alla tua s’affianca.
CON I NEON NEL CUORE
sempre aperti per confondermi
le idee. perché aspettavo che il silenzio si adagiasse
nell’antro del cuore (farfalla dalle ali stropicciate)
e tu avresti dovuto abbatterlo nei pressi
di fontana di Trevi dove ho vissuto i momenti più felici
e quelli più duri, farciti con il fiele dell’esilio,
con il soffio della tua esistenza, con il tuo corpo che avrebbe potuto
accogliere il mio. ho provato, sai, a seguire il canto: il sordo rumore
delle rose era assordante. i ricordi. le facce. i pensieri che sbattono
nel cervello i piatti per delle ore. meglio, allora, lanciarsi dal ponte
coi professori-poeti e i poeti di professione, io sto con gli sguatteri
della poesia. tornare all’ombra tangibile, allo scarto di se stesso,
alle menzogne sincere, al taglio della mano e carne, lingua e naso.
alla verità impudica che sanguina persino sui manifesti pubblicitari.
il giardino (mia tomba odorosa) e avrò sempre bisogno dello sguardo
della tua forma che scroscia dalle altre mille immagini di Roma:
a festa illuminata e persa dietro il fiume in fiamme, ai neon,
al nido di lamiere, teli di plastica e cartoni dei rifugi dei derelitti.
ai patinati e giganteschi oggetti (calze, orologi, auto, profumi...)
reclamizzati da visi perfetti, da corpi ginnici abbronzati e ardenti.
trovi la traccia persino nei volti dei passanti
di questa malattia che, in effetti, non lascia scampo: ci cala dritti nel pozzo
poi lentamente ci affonda (acre oblio del sonno) nelle sue morbide braccia.
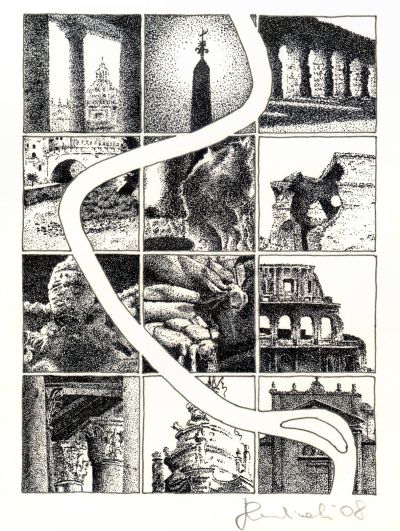
Il disegno che chiude il libro,
di Stefano Cardinali
Nessun commento:
Posta un commento