Fara Editore, 2010
recensione di Davide Puccini pubblicata su «Pagine», Anno XX, n. 62, agosto-novembre 2010, p. 50.
In questo terso ed intenso libro di poesia Rosa Elisa Giangoia ci racconta l'esperienza dolorosa della morte di una persona cara con cui ha condiviso l'ultima parte della sua vita, e lo fa senza non dico edulcorare ma nemmeno travestire la realtà ed anzi quasi redigendone scrupolosamente la cronaca, momento per momento, ad occhi asciutti. La parola si offre nuda, senza abbellimenti; eppure il miracolo della poesia, che non conosce regole ma solo eccezioni, consente anche questo: che essa viva di vita propria grazie alla forza del sentimento che la anima, tanto più forte e avvertibile quanto meno esaltato dall'artificio letterario. Il discorso si apre con il ricordo della breve felicità goduta insieme: «siamo entrati dalla porta della gioia /nella casa diventata nostra»; «arderci di sale sul mare […] muoverci nell'oceano del silenzio, / persi nell'azzurro e nella brezza». Ma la morte è in agguato: «la Gorgone […] scrutava le nostre vite / e sotto il mare ci avvolgeva / nelle sue trecce di serpente»; la malattia giunge all'improvviso e inesorabilmente: «Poi io ti ho dovuto dire / che il tuo corpo ormai / era una sequenza particolare / programmata per l'estinzione»; «E tu hai dovuto imparare / (e imparasti in fretta / perché capisti che il tempo era poco) / ad arricchirti di coraggio […] mentre io ammiravo / il tuo esercizio per diventare / capace di morire». La realtà del dolore è affrontata direttamente, a viso aperto, nella vita come nella poesia, che assume un tono lapidario e memorabile perché svolge il compito di consegnare per sempre al futuro atti e parole e riflessioni: «Bisogna prendere dalla vita / le parole per dire la morte / che non ha parole»; «E rimase il dilemma se la morte / fosse fine o transito, / se facesse della vita / un cerchio o un arco». Il momento del trapasso ci viene consegnato in modo indimenticabile: «L'ultimo mattino (era domenica) / io ti guardavo / e tu vedevi che io ti guardavo / e io capivo che tu te ne rendevi conto / e io vedevo che tu capivi che io ti guardavo, / e io volevo oltrepassare lo sguardo, / finché tu vedesti il ricapitolarsi /del tuo vivere nel suo perdersi / e poi nessuno dei due vide più nulla, / con gli occhi della vita […] e non mi restava / che il vivere nell'assenza». Nella fissità di questo silenzioso dialogo di sguardi c'è tutto lo strazio di un dolore senza esibizione di lacrime, e assenza sarà d'ora in poi la parola chiave del libro.
Ma bisogna mettere in evidenza qualche altro passaggio determinante, in primo luogo la sottolineatura del valore della sofferenza: «Nella vita coglie la verità / chi non è inesperto di sofferenza, / perché attraverso il soffrire / l'invisibile si fa visibile», che è come dire, semplicemente, che attraverso la sofferenza possiamo vedere dietro le apparenze del visibile, dove Dio si manifesta agli uomini. E ancora: «Ma ora tu sei avanti, / molto avanti nel sapere / perché hai attraversato il filo della spada / e sai dove si va e che cosa c'è / oltre il suo taglio», che è un'immagine efficace della sottilissima, affilata linea di separazione tra la vita e la morte, al di là della quale si situa la conoscenza della vita oltre la morte. Tuttavia le parole sono sempre insufficienti a esprimere l'esperienza della morte, come si sostiene in questa sorta di poetica dell'ineffabile, che dice di non poter dire mentre dice: «I funerali sono crudeli / perché finiscono / negli abituali sussurri senza fine / di scambi di parole sprecate […]; / le parole sono il nostro limite, /piangono sé stesse / e se ne vanno, / come se morto / fosse un aggettivo qualsiasi». Ma, significativamente, è proprio la parola che finisce per trionfare: «È troppo duro cercare un cuore caro / sotto la freddezza liscia / del marmo della lastra / e poter lasciare solo un fiore di seta / per dire l'affetto: / consola sentire che le parole più belle / ancora ce le dobbiamo dire». Mentre l'avvicinarsi della propria fine diventa un naturale girare della ruota della vita: «E ora così / li ho dovuti accompagnare / proprio tutti, / mia mamma e mio papà, / mia zia e mia suocera, / mio marito. / E non mi resta / che immaginare qualcuno / che accompagnerà me».
La vicenda è simmetricamente incorniciata tra due dipinti, non capolavori famosi di qualche museo, ma pregevoli quadri di famiglia del Seicento genovese, riprodotti in copertina e in quarta di copertina, a cui corrispondono due testi: il primo, la Madonna Addolorata di Domenico Fiasella, «ti avrebbe insegnato / la maniera umana di morire / per fare dell'individuale eccezione / la generale condivisa normalità / dell'essere ri-consegnato»; l'altro, la Madonna col Bambino di Gioacchino Assereto, «sullo sfondo di un cielo / forse per te ora non irraggiungibile», diventa una possibile promessa di paradiso.
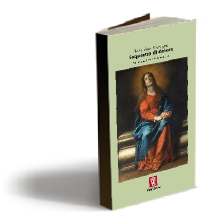
Nessun commento:
Posta un commento